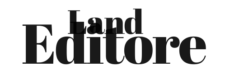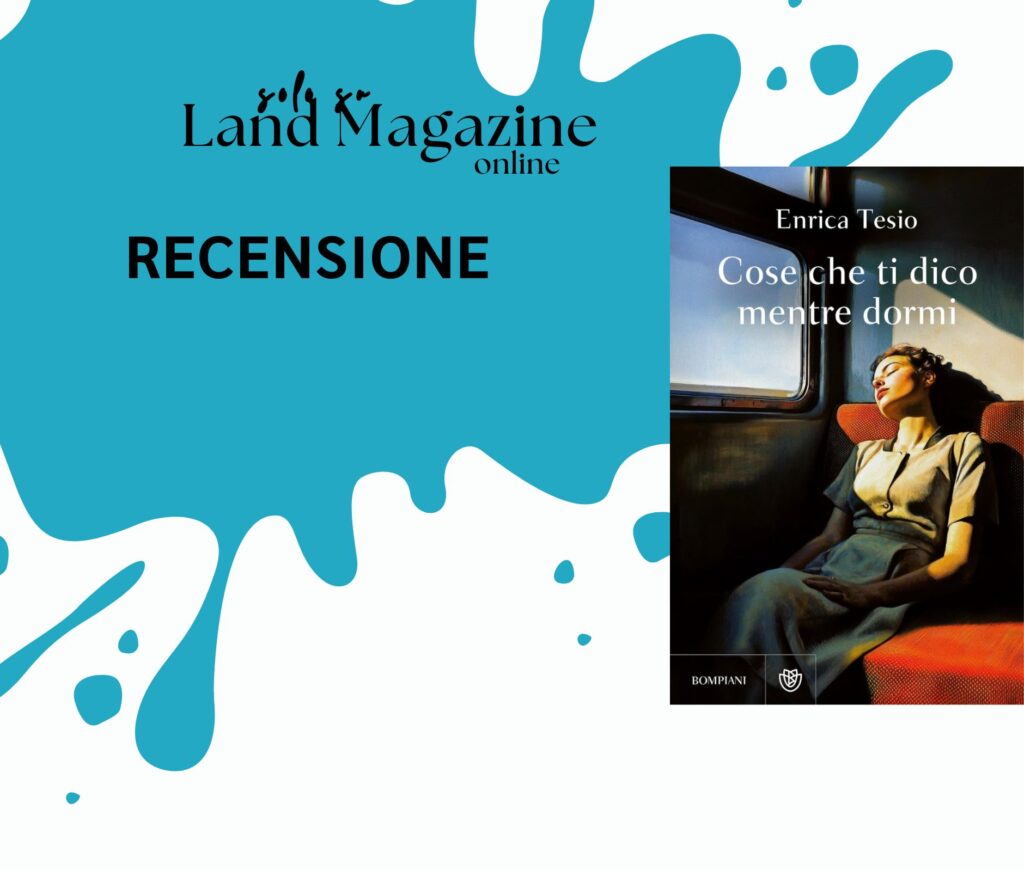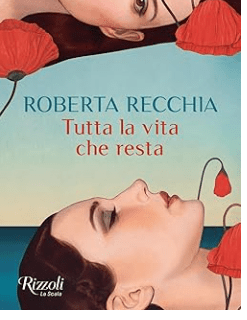C’è qualcosa che stiamo ignorando. C’è un impatto, enorme, sul mondo della scuola che si sta consumando nel silenzio pressoché totale di insegnanti, dirigenti, burocrati e, non da ultimo, dei genitori. Questo impatto si chiama ChatGPT. ChatGPT è un chat bot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico. Si tratta di un software che simula il ragionamento umano, che è in grado di dialogare con noi e di rispondere alle nostre richieste. Può scrivere un testo, e può farlo secondo l’esatto stile che chiediamo, fosse anche quello di un ragazzo di terza media. Può stilare un articolo, una poesia, un saggio. Perfino, se gli dessimo indicazioni man mano (ma nemmeno troppe), una intera tesi di laurea. Può eseguire, in sostanza, molti dei compiti che facciamo noi adesso, attraverso il nostro lavoro. E può imparare. Fagocita una enorme quantità di dati e testi, in una sorta di snowball effect. Ovvero, ChatGPT si nutre dei dati personali e dei meccanismi di feedback degli utenti rafforzando ulteriormente l’algoritmo. ChatGPT ha modo di capire dai suoi errori e migliorare. Utilizza l’apprendimento supervisionato su una vasta mole di testi per generare contenuti che risultano significativi e coerenti, come se si trattasse di un testo scritto da una persona. A differenza della maggior parte dei chat bot, inoltre, ChatGPT ha la capacità di ricordare le interazioni precedenti avvenute all’interno di una stessa conversazione. Questa tecnologia, messa a disposizione del grande pubblico nel novembre del 2022, è ancora in gran parte da esplorare e da comprendere fino in fondo, e i quesiti sorti nel frattempo sono molti. Diventerà sempre più intelligente? Che tipo di addestramento viene praticato inizialmente e da chi? C’è il rischio che qualcuno educhi queste piattaforme in modo distorto, producendo un rischio per l’utente finale e l’opinione pubblica? E poi la sfida, non ultima in senso di importanza, è capire come l’AI possa lavorare al nostro servizio e non al nostro posto. Una sfida che riguarda sempre di più la scuola. Chat GPT e la scuola E qui viene il nodo del problema: gli studenti, dalle scuole medie in su, per i compiti a casa stanno usando ChatGPT. Potenzialmente per fare tutto. Traduzioni dall’inglese. Compiti di italiano. Ricerche su ogni genere di argomento. Problemi di matematica. È facile. Si inserisce il comando a Chat, e Chat esegue. Chat, poi, non ha i limiti di Google, che fornisce risultati uguali e preconfezionati per tutti. Le risposte che dà, parlando di ambito creativo, sono ogni volta originali, diverse. E pertanto non riconoscibili come fornite da una macchina. Sembrano, cioè, formulate da un essere umano. Vediamo un esempio concreto. Un tempo l’insegnante chiedeva per compito agli alunni una cosa come: fate una ricerca su una donna importante per la storia. Un certo numero di studenti avrebbe cercato on line e magari su qualche libro a disposizione. Avrebbero poi rielaborato con parole loro. Un altro gruppo si sarebbe limitato a fare un copia-incolla da qualche sito senza starci a pensare troppo. In questo caso, il professore che avrebbe voluto scoprire l’inganno avrebbe avuto vita facile. Basta infatti prendere una frase, inserirla pari pari su Google per trovare la fonte e il gioco è fatto. Cosa impossibile con ChatGPT. Fino a qualche tempo fa, spiega in un articolo Marco Andreoli, docente in Scritture per lo Spettacolo dal Vivo alla Sapienza di Roma, «bastava inserire una o più frasi del compito sospetto, per verificarne l’eventuale originalità. Ora però anche gli studenti adolescenti hanno imparato a utilizzare strumenti come ChatGPT, ciascuno di loro può chiedere all’Intelligenza Artificiale di elaborare una relazione sul mito di Orfeo (esempio che ha citato in precedenza nell’articolo, ndr), ricevendo, nel giro di qualche secondo, testi originali di cui sarà pressoché impossibile riconoscere la provenienza». Il vantaggio in termini di tempo è schiacciante: se un ragazzo ci mette ore e fatica per fare una propria ricerca personale, ChatGPT impiega solo pochi istanti. Il problema forse più grave è che tutto ciò sta avvenendo sotto il silenzio di (quasi) tutti. Tranne pochi docenti che si stanno accorgendo della cosa e cercano di porre rimedi più improvvisati che strutturali, l’impressione è di avere di fronte una rete di omertà che, in effetti, si fatica a spiegarsi. Forse siamo ancora attoniti, cerchiamo di dare poca importanza alla cosa come fosse una moda passeggera, forse nascondiamo la testa sotto la sabbia, forse non la capiamo bene. Forse le cose prima di essere comprese vanno elaborate, pensate, ci vuole tempo. E forse tutto ciò comporta fatica, e allora si preferisce intanto fare finta di nulla. Ma le conseguenze sono serie, e ne va di mezzo l’apprendimento degli studenti. «I professori dovranno ripensare ai compiti a casa – ha dichiarato Paolo Ferri, professore ordinario di Tecnologie della formazione all’Università Milano-Bicocca – puntando proprio sulle esperienze dei ragazzi. E poi i momenti di verifica dovranno essere necessariamente fatti in classe, meglio ancora se oralmente». Tentativi che in qualche modo cercano di rattoppare una falla che pare sempre più grande. Una snowball divenuta valanga. La sensazione è che manchi un intervento più organico e coordinato, “dall’alto”. Segno che la giurisprudenza e le istituzioni spesso faticano a stare al passo con i tempi della tecnologia. Ma intanto iniziare a parlarne potrebbe essere il primo passo per aprire un serio dialogo sul tema.