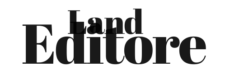Masterclass Vita d’Altri: episodio otto
In collaborazione con Eredità Racconto di Roberto Zito Questo racconto è stato ideato e scritto da uno degli allievi della scuola di Scrittura e Storytelling Viagrande Studios, in occasione della masterclass Vita d’altri. Editing a cura di: Manuela A.De Quarto L’ultimo scherzo me lo avevano fatto prima di morire. L’arbre magique che aveva l’odore dello […]
Masterclass Vita d’Altri: episodio otto Read More »